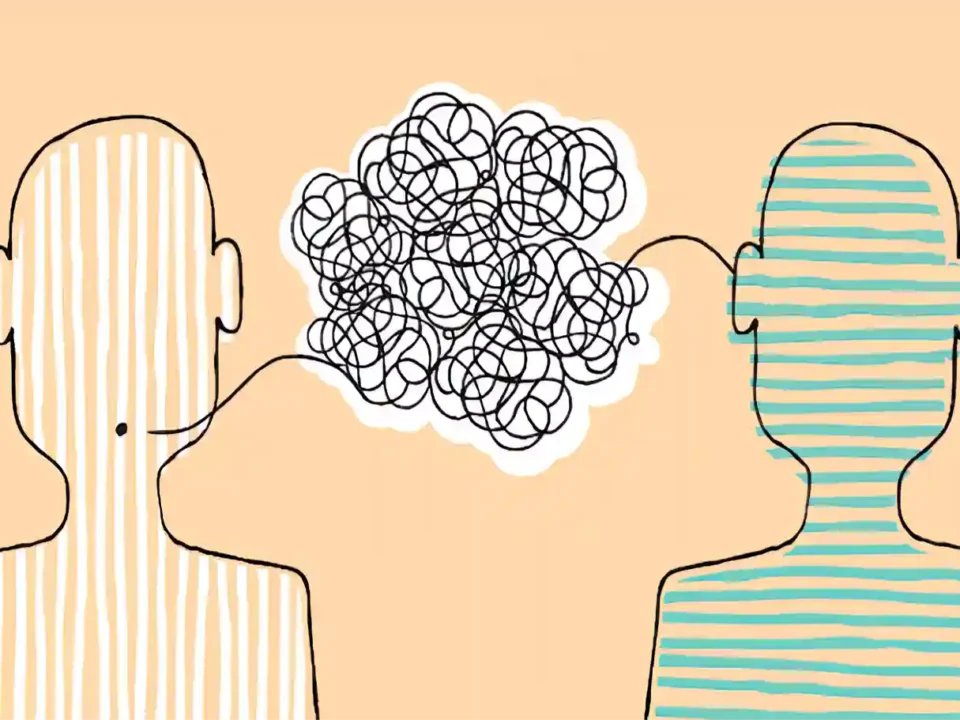DAL PUNTO DI VISTA DELLE PMI: SFIDE E OPPORTUNITÀ PER UN FUTURO SOSTENIBILE
19 Ottobre 2024
Le leve motivazionali nella critica costruttiva
4 Novembre 2024IL LAVORO COME ESTENSIONE DELL’IDENTITÀ PERSONALE

Introduzione
In generale nel corso della storia chi aveva meno risorse lavorava di più rispetto a chi era benestante poi, ad un certo punto, più o meno negli anni ’90, la narrazione è cambiata. Le persone più ricche hanno incrementato le loro ore di lavoro, è iniziato qualcosa di diverso, un comportamento peculiare in cui il lavoro diventa un pensiero fisso. Robinson (1998) lo definisce il Workaholism, una “dipendenza ben vestita”, che si manifesta attraverso richieste auto-imposte, una incapacità di regolare le proprie abitudini di lavoro fino all’esclusione, o comunque alla marginalizzazione, delle altre attività di vita.
Le cause
In questo scenario il lavoro viene percepito come una fondamentale estensione dell’identità personale, in cui siamo portati a credere che il nostro successo professionale sia direttamente proporzionale al nostro valore come persone. Avere un lavoro è senz’altro una cosa importante, significa far parte di una società, poter esprimere le proprie opinioni e contribuire allo sviluppo del mondo in cui viviamo, e il bisogno di appartenenza è intrinsecamente umano. Le organizzazioni, infatti, desiderano lavoratori non solo competenti, ma anche capaci di identificarsi con entusiasmo e orgoglio nella mission aziendale, in modo tale che il coinvolgimento possa portarli a investire piacevolmente tempo ed energie. Tuttavia, a volte, l’investimento nel lavoro può risultare eccessivo e tramutarsi in Workaholism (o work addiction), ossia nella dipendenza dal lavoro. Una delle principali forze trainanti di questa condizione è la cultura della prestazione, il risultato, sempre e comunque, come misura del confronto sociale. Le persone che introiettano quest’idea, e ne fanno un valore fondamentale, rischiano di diventare vittime di aspettative e standard troppo elevati. È come se non si fosse mai soddisfatti di quanto prodotto e quindi si continuasse a lavorare verso un’ideale di perfezione che è, per definizione, irraggiungibile. Inoltre, questo fenomeno può svilupparsi anche come risposta imitativa a comportamenti messi in atto da superiori e colleghi, e per effetto di una cultura organizzativa che riconosce e premia tale condotta.
L’Influenza dei Social Media
L’avvento dei social media ha amplificato questa dinamica, creando un ambiente in cui le realizzazioni professionali sono costantemente esibite e messe a confronto. La pressione sociale di apparire sempre “occupati” e “realizzati” contribuisce a generare un ciclo di competizione che alimenta ulteriormente l’ossessione per il lavoro. Le persone sentono il bisogno di condividere i propri successi, creando una sorta di “ansia da prestazione”.
Le nuove generazioni
Non tutti però aderiscono a questo sistema. Le nuove generazioni si stanno lentamente distaccando dall’ossessione per il lavoro abbracciando un approccio più equilibrato e olistico alla vita professionale. Avere sempre l’agenda fitta di impegni lavorativi tanto da non poter dedicare tempo a sé stessi non viene più percepito come un valore. Forse i giovani sono più consapevoli del rischio di burnout e delle conseguenze psicologiche associate al Workaholism. Hanno probabilmente compreso che l’identità può essere costruita anche in altri modi.
Conclusioni
Questo cambiamento non è solo una reazione alla cultura del lavoro incessante, ma un passo verso una società più sana e consapevole, in cui il lavoro è solo una parte di una vita piena e soddisfacente. La sfida per le organizzazioni sarà quella di adattarsi a questa nuova mentalità, creando ambienti che valorizzino non solo la produttività, ma anche il benessere e la realizzazione personale.
Testo di Diego Ingrassia