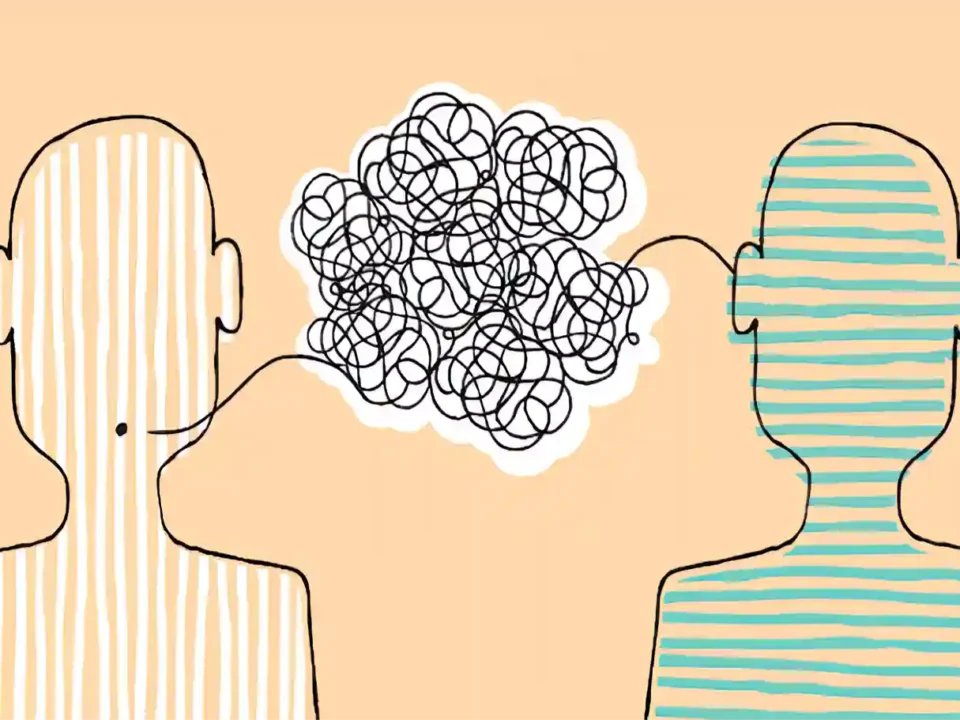RIFLESSIONI SULL’AMORE
14 Febbraio 2018
Agilità Emotiva
1 Marzo 2018Trasformare la cultura organizzativa per valorizzare l’intelligenza emotiva
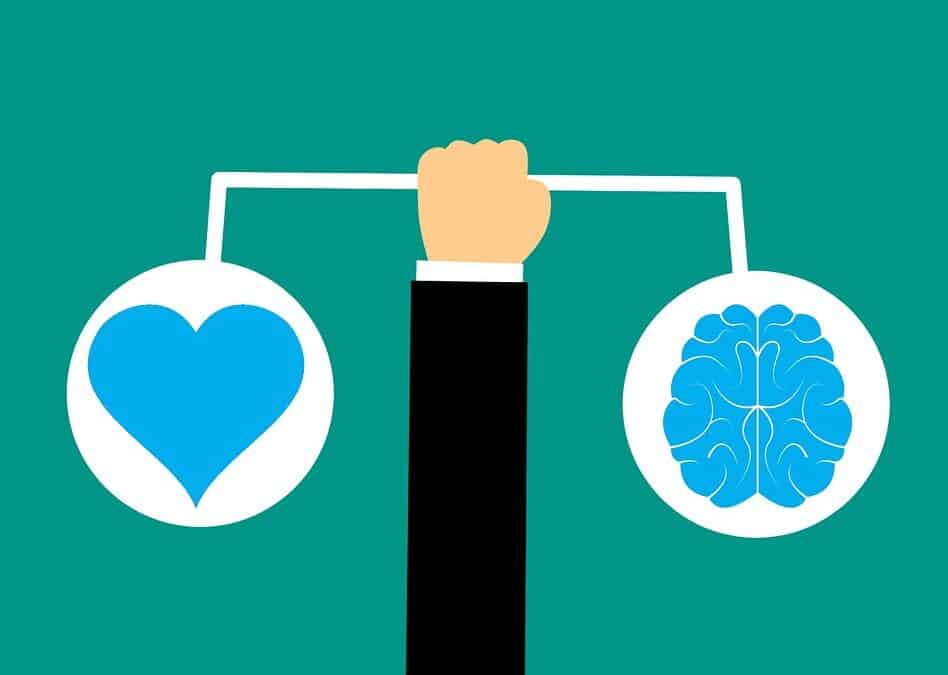
L’uomo detiene ancora un vantaggio competitivo rispetto all’intelligenza artificiale e agli algoritmi. Un potenziale non ancora compreso a pieno, specie all’interno delle organizzazioni, consiste nella capacità di provare e gestire le proprie emozioni. In un contesto in cui le ricerche rivelano la diffusa incapacità dei capi di provare empatia nei confronti dei propri collaboratori, risulta prioritario trasformare la cultura organizzativa, per tornare a dare valore all’umanità della persona, racchiusa nelle sue emozioni.
Lunedì 5 febbraio 2018 è stato un giorno nerissimo per la Borsa di Wall Street, la peggior seduta dal 2011.
L’indice Dow Jones è arrivato a perdere il 6% per poi fermarsi a -4,6%: un calo analogo ha coinvolto anche tutte le Borse asiatiche, le Borse europee hanno reagito con maggior equilibrio denunciando comunque considerevoli perdite.
Cosa è accaduto?
A giudizio degli analisti, le notizie dello storico accordo sindacale in Germania nella regione del Baden-Württemberg che prevede aumenti salariali del 4,3% per 900mila lavoratori, che presto potrebbe essere esteso alla totalità dei 3,9 milioni di metalmeccanici tedeschi, insieme con notizie analoghe provenienti dagli Stati Uniti, hanno innescato una serie di automatismi comandati da algoritmi istruiti per reagire quando si modificano alcuni parametri legati all’indice di volatilità, provocando a cascata un’ondata di vendite sui mercati.
È sensato tutto questo? Sicuramente no.
La notizia di aumenti salariali su larga scala è ottima per l’economia reale, oltre a concorrere al benessere di molte famiglie, produce nel tempo un aumento dei consumi e quindi un vantaggio per i mercati.
Perché quindi è potuto accadere questo?
Mettiamo da parte considerazioni che potrebbero indurci a riflettere su quanto i meccanismi delle Borse siano lontani dall’economia reale, estranee per altro al tema di questo articolo, e concentriamoci invece su un dato reale: il 66% dei miliardi di scambi che avvengono ogni giorno sulle Borse mondiali è governato da algoritmi, macchine che decidono autonomamente.
Un qualunque livello di controllo guidato da persone non avrebbe mai fatto accadere tutto questo: c’è ancora molto spazio per l’intelligenza umana!
Ma quanto ne siamo consapevoli?
Quando l’intelligenza è potenza di calcolo non c’è partita tra l’intelligenza della macchina e quella umana: è noto che Deep Blue, un computer di IBM, nel 1997 è riuscito a battere in una partita di scacchi Garry Kasparov.
Ma la macchina non è consapevole di quello che fa, non ha coscienza, non ha emozioni: c’è qualcosa nell’intelligenza umana che non può essere ridotto a un algoritmo.
Conoscere le emozioni per gestirle al meglio
Contestualizzare gli elementi di senso di una decisione; garantire equilibrio emotivo e ragionevolezza nel processo decisionale; comprendere responsabilmente le conseguenze di una determinata scelta; essere capaci di fornire risposte anche di fronte a situazioni ambigue, tollerare l’incertezza; agire comunque, se necessario, anche in assenza di una procedura o di un programma: sono caratteristiche peculiari dell’intelligenza umana.
Ma gli studi dedicati a comprendere questa intelligenza hanno una storia breve.
Non bisogna avere molti anni –e forse le cose non sono molto diverse neppure oggi– per ricordare che durante gli anni della scuola l’intelligenza che contava era quella di tipo logicomatematico.
Per poi approdare nel mondo del lavoro e ricevere insegnamenti pronti a ricordarci di “lasciare le emozioni al di fuori”: una mente razionale, lucida e distaccata fornisce le migliori prestazioni.
Non dobbiamo dimenticare quindi che il cammino che ha portato a riconoscere le emozioni come una componente essenziale della nostra intelligenza è stato –almeno all’interno della nostra civiltà– lungo e difficile, e per quanto sia possibile individuare contributi di enorme rilevanza nell’opera di alcuni grandi filosofi, a partire da Aristotele, per arrivare al fondamentale saggio di Charles Darwin The Expression of the Emotions in Man and Animals, è solamente a partire dai lavori di Peter Salovey e John D. Mayer (1990) che il tema dell’intelligenza emotiva si impone nel dibattito scientifico.
Per molto tempo quindi l’unica intelligenza riconosciuta come tale è stata quella riconducibile al pensiero logico e razionale.
Ancor oggi i test basati sul quoziente di intelligenza (QI) sono ampiamente presenti nei test di ammissione a molte facoltà universitarie, così come esiste un club esclusivo (Mensa) la cui appartenenza è vincolata al superamento di una certa soglia ‘quantitativa’ del QI.
Eppure, la nostra intuizione avrebbe potuto da sola indicarci che un tale approccio risulta essere riduttivo, in quanto tutte le nostre decisioni sono influenzate dalle nostre emozioni e solo in un successivo momento tendiamo a spiegare le nostre scelte attraverso il pensiero razionale. Dobbiamo agli studi di Paul Ekman, il massimo esperto della fisiologia delle emozioni, la dimostrazione che Darwin aveva ragione sull’origine biologica e adattiva delle emozioni, perché alcune di esse si manifestano sul volto degli esseri umani nel medesimo modo in tutte le culture del mondo.
Aver scoperto questa matrice universale e la natura innata delle sette emozioni primarie (paura, rabbia, tristezza, felicità, disgusto, sorpresa, disprezzo) ci ha aiutato a comprendere in modo più approfondito la natura delle emozioni e la loro importanza, non solo nel corso dell’evoluzione della nostra specie, ma nella nostra vita di tutti i giorni. “Le emozioni accadono”, afferma Ekman: non possiamo sceglierle, le emozioni ci accompagnano nel corso della vita, si mescolano ai nostri pensieri per generare ricordi, colorano le nostre esperienze e quando non siamo soddisfatti della intensità emotiva a cui siamo esposti, guardiamo film, andiamo a teatro, leggiamo libri, frequentiamo persone che suscitano in noi emozioni… Ma per quanto siano importanti, ci ricorda Ekman, le conosciamo ancora molto poco.
L’intelligenza emotiva è ancora poco valorizzata nei luoghi di lavoro
Come abbiamo visto è a partire dai lavori di Salovey e Mayer del 1990 che si anima il dibattito scientifico attorno all’intelligenza emotiva, ma in realtà è solo attraverso l’opera di divulgazione di Daniel Goleman, iniziata con il testo Emotional Intelligence del 1995 (tradotto in Italia nel 1997), che questo tema comincia a riscuotere interesse anche al di fuori dell’ambiente accademico.
Chi segue il mondo della formazione può probabilmente retrodatare questo interesse a partire dall’inizio degli Anni 90, quando all’interno di organizzazioni che diventavano sempre più articolate e complesse, si è cominciato a sentire il bisogno di strumenti che potessero comprendere la performance lavorativa anche al di là della sua componente tecnico-specialistica, e si sono adottati modelli basati sul concetto di competenza e di soft skill, derivati dagli studi di David Mc- Clelland e portati in Italia da Piero Quaglino.
Ma il merito degli studi dedicati all’intelligenza emotiva è di aver dato vita a un costrutto che sintetizza in modo efficace un insieme di qualità (conoscere le proprie e le altrui emozioni; saperle gestire; motivare se stessi; saper utilizzare queste competenze nella relazione con gli altri), facilmente riconducibili a comportamenti efficaci.
Goleman riporta nei suoi libri numerosi esempi di successo da parte di persone emotivamente intelligenti e sostiene che coloro che hanno queste caratteristiche si distinguono nel mondo del lavoro perché sono capaci di realizzare migliori performance.
In base alla nostra esperienza possiamo confermare queste osservazioni: le persone capaci di riconoscere, accettare e gestire in modo consapevole le proprie emozioni riescono a instaurare relazioni positive e sono capaci di affrontare meglio e con maggiore equilibrio le situazioni difficili.
Ma la nostra esperienza ci ha anche fatto incontrare manager di successo, ai vertici nelle loro organizzazioni, caratterizzati da un’intelligenza emotiva molto bassa. Poco attenti a quanto accade attorno a loro a livello relazionale e unicamente concentrati sugli obiettivi di business.
Di fronte a queste situazioni è lecito chiedersi: è davvero indispensabile l’intelligenza emotiva?
Per rispondere a questa domanda bisogna aprire una breve riflessione sulla cultura organizzativa e sui modelli di leadership.
I modelli culturali cambiano, ma in genere cambiano molto lentamente. Oggi sempre meno persone sono disposte ad accettare di essere guidate attraverso metodi autoritari: è cambiata la società, sono cambiati i modelli educativi all’interno delle famiglie, abbiamo speso molte parole per far comprendere la differenza tra autoritarismo e autorevolezza, e possiamo dire che questo è un dato in larghissima misura compreso e condiviso.
Ma quante persone amano ancora l’uomo forte al comando?
Il cosiddetto ‘uomo forte’ (potrebbe anche non appartenere al genere maschile) non è per definizione autoritario, ma è deciso, sicuro, determinato, carismatico.
Siamo di fronte a uno stereotipo poco in sintonia con l’accettazione delle proprie emozioni, culturalmente viste ancora come un segno di debolezza. Ma quando si cerca di cancellare questa componente, che non è possibile annullare data la sua natura biologica, non si fa altro che innescare un processo destinato lentamente a scoppiare.
Aumenta la competizione interna, così come il livello di stress individuale e collettivo, insorgono conflitti che si cerca di sedare senza cercare di comprendere, altri reagiscono assumendo un atteggiamento rassegnato e remissivo.
Alla fine, all’interno di un clima divenuto estraneo al riconoscimento personale e alla gratificazione, chi può se ne va.
È necessario allora promuovere un cambiamento della cultura organizzativa. Se vogliamo immaginare gruppi di lavoro emotivamente intelligenti –e per fare questo dobbiamo essere capaci di generare modelli di confronto e di comunicazione più aperti e flessibili– dobbiamo rinunciare a facili scorciatoie ed essere disposti ad accettare maggiore complessità: alimentare l’ascolto, la fiducia reciproca e un clima di cooperazione.
L’agilità emotiva e le nuove competenze manageriali
Studi recenti sembrano confermare le ricerche condotte a Berkeley dallo psicologo Dacher Keltner che aveva coniato la definizione di “paradosso del potere”.
Keltner aveva notato come nel tempo l’esercizio del potere tende a far perdere alle persone alcune delle doti che hanno consentito loro di ottenerlo.
In particolare, aveva riscontrato una limitata capacità di entrare in sintonia con le persone con cui erano in relazione e di riuscire a comprendere cosa loro stessero provando.
Queste intuizioni sono state confermate da Sukhvinder Obhi, un neuroscienziato della McMaster University in Ontario, che ha condotto una serie di esperimenti usando la tecnica della Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS), attraverso i quali ha potuto appurare che l’esposizione al potere danneggia il funzionamento di alcune strutture cerebrali, i neuroni a specchio, che come è noto sono alla base della nostra capacità empatica.
Questi brevi spunti sulla cultura della leadership ci aiutano a comprendere anche in una prospettiva più ampia qual è la sfida che la riflessione sul tema dell’intelligenza emotiva ha avviato all’interno del mondo del lavoro. Come abbiamo visto i modelli culturali nelle organizzazioni cambiano molto lentamente, la resistenza al cambiamento è un fenomeno ben conosciuto, le persone hanno bisogno di tempo per potersi adattare. Attorno a noi però c’è un mondo che cambia a una velocità impressionante: l’innovazione tecnologica, gli effetti della globalizzazione, l’immigrazione, una società sempre più complessa e multietnica, l’enorme quantità di informazioni da gestire, comunicazioni frenetiche sempre più disattente alla componente emotivo-relazionale.
Non possiamo certo trasformarci in luddisti del Terzo Millennio, anche perché ormai è tutto immateriale ciò che dovremmo distruggere.
La “agilità emotiva”, come l’ha definita Susan David in un suo recente libro, è una qualità dell’intelligenza emotiva che ci può aiutare ad alleviare lo stress e a trovare nuove risorse coordinandoci con il nostro ‘cervello emotivo’ proprio quando la nostra rigidità cognitiva rischia di farci cadere in trappola.
“Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce” è un celebre aforisma di Blaise Pascal che riassume mirabilmente il ruolo e l’importanza dell’intelligenza emotiva con tre secoli di anticipo sui lavori di Salovey e Mayer.
Il contributo più importante degli studi sull’intelligenza emotiva forse è proprio questo: ricordarci che in questa sintesi tra cuore e ragione, che trova sempre più conferme in recenti acquisizioni delle moderne neuroscienze, risiede il valore più profondo dell’intelligenza umana.